

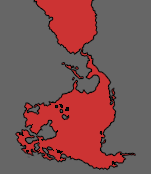
“Mi hanno ordinato di mettere la testa in una pozza di sangue”
Lettera di Valentina Palma, documentarista cilena espulsa per i fatti di Atenco
di Valentina Palma Novoa
12 maggio 2006
Il mio nome è Valentina Palma Novoa. Ho 30 anni, gli ultimi undici vissuti in Messico. Sono laureata alla Scuola Nazionale di Antropologia e Storia e, attualmente, frequento il quarto anno di Cinematografia presso il Centro di Formazione Cinematografico.
Ho un visto FM 3 (visto residente) per studio.
Di seguito, vorrei relazionarvi sui fatti di cui sono stata testimone durante i violenti incidenti verificatesi nel villaggio di San Salvador Atenco giovedì 4 maggio 2006, che sono terminati con la mia espulsione dal paese in maniera ingiusta ed arbitraria.
1. – Mercoledì 3 maggio, dopo aver visto le notizie in televisione e venuta a conoscenza della morte di un bambino di 14 anni, come antropologa e documentarista mi sono molto commossa per la morte del piccolo, per cui decisi di dirigermi a San Salvador Atenco a registrare la situazione reale del paese.
 Valentina Palma Novoa Photo: Indymedia Chiapas |
Saranno state le 6 del mattino quando le campane della chiesa di San Salvador Atenco hanno cominciato a suonare – dong, dong, dong, dong – mentre correva voce che la polizia stesse assediando il villaggio. Le biciclette andavano da una parte all’altra. La panetteria a fianco della chiesa aveva aperto appena ed il profumo del pane inondava la strada, insieme all’andirivieni dei contadini in bicicletta. Il signore che vendeva atoles mi disse di fare attenzione che quelli che stavano arrivando “erano dei veri bastardi”.
Mi sono diretta ad uno dei posti di guardia dove i contadini osservavano il branco di poliziotti che si vedevano in lontananza. Ho inserito lo zoom alla macchina fotografica. Ho visto che erano molti e che, coperti dai loro scudi, avanzavano a piccoli ed impercettibili passi. Ho avuto paura. Loro erano tanti, molto armati, ed i contadini pochi e disarmati. Sullo schermo della mia macchina fotografica vedo uno dei poliziotti che prende la mira e spara verso noi un proiettile che, quando mi è caduto di fianco, ho sentito era un lacrimogeno. Rapidamente sono piovuti altri lacrimogeni annullando il profumo del pane e trasformarono l’angusto vicolo in un campo di battaglia.
L’aria era ormai irrespirabile e sono andata sulla piazza mentre le campane suonavano con più forza. In lontananza, si vedeva la polizia avanzare per le diverse strade. La scarsa resistenza da parte dei contadini è cessata davanti all’attacco delle forze di polizia che bruscamente si sono scagliate sugli abitanti. Ho spento la mia macchina fotografica ed insieme agli altri mi sono messa a correre più forte che potevo. Davanti alla chiesa c’era un edificio pubblico con le porte aperte e lì mi sono rifugiata ad aspettare illusoriamente che le turbolenze cessassero. Lì c’erano anche due giovani che ingenuamente si riparavano dall’attacco. Eravamo tre e ci guardavamo in viso, angosciati e con paura.
Mi sono affacciata con cautela sulla strada ed ho visto cinque poliziotti come picchiavano con manganelli e calci un anziano a terra senza compassione alcuna. Ho provato ancora più paura. Sono tornata dagli altri due ragazzi dicendo che dovevamo nasconderci meglio perché lì eravamo molto esposti. Siamo saliti sulla terrazza e ci siamo sdraiati supini mentre vedevamo gli elicotteri che come calabroni sorvolavano nel cielo, mentre il rumore degli spari era entrato a far pare del paesaggio sonoro del luogo. Una voce d’uomo, violentemente, ci gridava: “tirate giù quegli stronzi dalla te terrazza”.
Per primi hanno tirato giù i due ragazzi. Io, dall’alto, vedevo come li picchiavano e, presa dal panico, non volevo scendere, allora un poliziotto ha gridato: “scendi cagna, scendi ora”.
Sono scesa lentamente, terrorizzata nel vedere come picchiavano sulla testa i due ragazzi. Due poliziotti mi hanno presa mentre altri mi picchiavano con i manganelli sui seni, sulla schiena e sulle gambe. Urlavo di dolore quando ho sentito la voce di qualcuno che chiedeva il mio nome per la lista di detenuti. Ho risposto: “Valentina… Valentina Palma Novoa”, mentre un poliziotto mi ordinava di chiudere la bocca ed un altro mi picchiava sui seni.
Una voce maschile ha ordinato di coprirmi con gli scudi perché non vedessi come mi picchiavano. Ci hanno portato di lato alla chiesa dove c’erano altri fermati e lì hanno ordinato di mettere le mani sulla testa. Continuavano a picchiarci. Il mio cellulare è suonato ed una voce ha ordinato di perquisire la mia borsa. In quel momento mi hanno preso la mia videocamera, il mio cellulare ed il mio borsellino con i documenti e cinquecento pesos.
Mi hanno sollevato per i capelli e mi hanno detto “sali sul furgone puttana”. Riuscivo a muovermi appena ma loro volevano estrema rapidità nei movimenti. Mi hanno spinto su ad altri corpi feriti e sanguinanti e mi hanno ordinato di abbassare la testa su una pozza di sangue, io non volevo mettere la mia testa nel sangue e lo stivale nero di un poliziotto sulla mia testa mi ha obbligato a farlo. Il furgone ha acceso il motore e durante il tragitto sono stata palpeggiata dalle mani di molti poliziotti. Ho chiuso gli occhi e stretto i denti sperando che non accadesse il peggio.
Con i pantaloni abbassati, il furgone si è fermato e mi è stato ordinato di scendere. Goffamente sono scesa ed una donna poliziotta ha detto: “lascia a me questa cagna” e con le due mani mi ha picchiata sulle orecchie. Sono caduta e due poliziotti mi hanno sollevato per farmi salire sull’autobus passando tra una fila di poliziotti che ci prendevano a calci.
Sull’autobus un’altra poliziotta donna ha chiesto il mio nome mentre due poliziotti mi strizzavano i seni con brutalità e mi buttavano sul corpo di un anziano il cui viso era una crosta di sangue. Quando sono caduta col mio corpo sul vecchio, lui ha gridato di dolore. Ho tentato di muovermi ma un calcio sulla schiena mi ha fermato. Il mio grido ha fatto gridare ancora il vecchio che chiedeva pietà a dio.
Una voce di donna mi ha ordinato di mettermi sui gradini posteriori dell’autobus. Così ho fatto e da lì ho potuto vedere i volti insanguinati degli altri fermati ed il sangue sul pavimento. Anche se io non stavo sanguinando, le mie mani ed i vestiti erano sporchi del sangue degli altri fermati.
 Photo: D.R. 2006 Ratón Maicero |
Ho pianto amaramente. Ho creduto che il vecchio sarebbe morto al mio fianco. Ho mosso la mano per toccarlo per dargli un po’ di calma. Mi è arrivata una manganellata sulla mano, e con un gesto, ho chiesto compassione al poliziotto che ha smesso di picchiarmi. Volendo dargli un po’ di amore, ho accarezzato la gamba del vecchio che per un po’ ha smesso di lamentarsi.
Gli ho chiesto il nome e lui mi ha risposto. “Se muoio non piangete, per favore fate una festa”. Ho pianto in silenzio sentendomi sola in compagnia degli altrettanti corpi picchiati, pensando al peggio, che ci avrebbero portato chissà dove, lì ammazzato e fatti sparire.
Per un momento mi sono addormentata. Ma l’odore di sangue e morte mi ha svegliato. Quando ho aperto gli occhi ho visto il muro di una prigione. L’autobus si è fermato ed una voce ha ordinato di scendere dalla porta posteriore.
Mi hanno ordinato di stare ferma e la porta si è aperta ed in lacrime ho visto una fila di poliziotti. Ho avuto un’altra volta paura.
Da sotto una voce ha ordinato di chiudere la porta e che i detenuti dovevano uscire col volto coperto. Un poliziotto mi ha coperto la testa col mio giubbotto e le porte si sono riaperte. Già dall’autobus un poliziotto mi ha afferrato con una mano per i pantaloni e con l’altra mi teneva la testa coperta. I poliziotti in fila hanno cominciato a tirare calci sul mio corpo e quello degli altri fermati.
La porta della prigione si è aperta e ci hanno portato per stretti corridoi in mezzo a botte e calci. Prima di arrivare ad un tavolo per la registrazione ho commesso l’errore di alzare la testa e guardare negli occhi un poliziotto, il quale ha risposto al mio sguardo sferrandomi un pugno nello stomaco che mi ha tolto l’aria per alcuni momenti.
A tavolo hanno chiesto il mio nome, la mia età e nazionalità, dopo di che mi hanno messo in una piccola stanza dove una donna grassa mi ha ordinato di togliermi tutti i vestiti. Chiedeva rapidità davanti alla mia goffaggine dovuta alle botte. “Signora sono stata picchiata, per favore aspetti”, le dissi. Mi ha perquisito. Mi sono rivestita e di nuovo mi hanno coperto la faccia con il giubbotto.
Uscita dalla stanza hanno ordinato di fare una fila di donne per entrare a testa bassa nel cortile della prigione, che poi ho saputo era la prigione di “almoloyita” nella città di Toluca.
Devono essere state le due del pomeriggio di giovedì 4 maggio quando ormai ci trovavamo nelle strutture della prigione. Ci hanno portato in una mensa ed hanno separato gli uomini dalle donne. In un angolo, tra il pianto, noi donne ci raccontavamo le vessazioni delle quali eravamo state oggetto.
Una ragazza mi ha mostrato i pantaloni rotti e la sua testa aperta piena di sangue. Un’altra raccontava che l’avevano portata in mezzo a due furgoni, mentre la picchiavano e vessavano le dicevano: “ti ammazziamo puttana”.
Un’altra ragazza mi h detto che forse era incinta. Tutto tra pianti e strette di mano solidali. Lo stato di shock tra le donne era evidente. Davanti a noi gli uomini parlavano tra loro mentre noi osservavamo i loro volti insanguinati e deformati dal brutale pestaggio. In quel momento una donna si avvicina ed incomincia a fare alcuni nomi e chiede che ci separiamo dal gruppo.
Eravamo quattro: Cristina, María, Samantha, Valentina. Si unisce al gruppo un quinto: Mario.
Eravamo i cinque stranieri fermati. E’ arrivato un uomo che credo fosse il direttore della prigione e ci dice che qui eravamo sicuri, che nessuno ci avrebbe picchiato e che quello che era successo prima di entrare in prigione non aveva niente a che vedere con lui, come se dentro la prigione non ci avessero picchiato. Gli abbiamo chiesto di telefonare ma ci è stato rifiutato.
Nel frattempo i fermati visibilmente più feriti venivano portati nell’infermeria della prigione. Non erano alcuni né due, dei cento ed oltre fermati che eravamo, circa 40 erano feriti gravemente.
Uno dei primi ad andare è stato il vecchio moribondo che stava con me sul furgone e che non ho più rivisto.
E’ arrivato il turno di noi stranieri di andare a fare il controllo medico. Io avevo lividi sui seni, sulla schiena, sulle spalle, sulle dita, sulle cosce e sulle gambe. E’ stato raccomandato di eseguire una radiografia alle costole perché faticavo a respirare, radiografia che non è mai stata eseguita.
L’infermiera che prendeva nota ed il medico che mi ha visitato agivano con totale indifferenza per la mia persona e le ferite che presentavo. Sono uscita dall’infermeria ad aspettare che Cristina, María, Samantha e Mario finissero la visita. Dopo la pseudo visita medica ci hanno portato in una stanza per prendere le dichiarazioni.
Stranamente un funzionario uscito da chissà dove ci ha raccomandato di non dire niente, in contraddizione con quanto dicevano le persone dietro la macchina da scrivere.
“Va bene se non vuoi deporre, è un tuo diritto. Ma sarebbe bene che raccontassi quello che ti è successo”, mi diceva una funzionaria. Mentre rilasciavamo le dichiarazioni, sono arrivati sul posto molti uomini in cravatta che, con modi cordiali e gentili, ci hanno chiesto chi eravamo e come e perché eravamo arrivati al villaggio di Atenco, se per caso sapevamo come fosse pericolosa quella gente.
Ha cominciato a piovere e ci hanno portato nella mensa con tutti gli altri fermati. Ci hanno obbligato a sederci e non potevamo entrare in contatto con i fermati messicani. Se volevamo andare al bagno dovevamo chiedere permesso. Sono arrivati funzionari dei diritti umani a prendere le nostre dichiarazioni e fotografare le nostre lesioni. Le nostre testimonianze sono state prese senza interesse, meccanicamente.
Ci hanno obbligato a farci prendere le impronte digitali. Ci hanno fotografato di fronte e di profilo dicendoci che non era una schedatura, ma una necessaria registrazione perché molto probabilmente ci avrebbero rilasciato la mattina seguente. Una pentola di caffè freddo ed una scatola di biscotti sono stati la nostra cena.
A mezzanotte circa mi sono coricata su una dura panca di legno per tentare di dormire un po’. E’ stato impossibile… faceva freddo e non c’erano coperte. Dalla parte degli uomini, un rasta si è accorto della mia irrequietezza per non riuscire a dormire ed abbiamo cominciato a parlarci, da un lato all’altro, con i segni. In quel mentre arriva un secondino e comincia a fare i nomi dei cinque stranieri. Ci alziamo, abbiamo dato un piccolo addio agli altri fermati ed abbiamo lasciato il posto.
Ci hanno portato in un ufficio. Ci hanno consegnato le nostre poche cose e ci hanno portato su un veicolo dicendoci che ci avrebbero condotto in un ufficio di migrazione a Toluca. Fuori della prigione ho sentito delle voci conosciute che gridavano il mio nome. Mi sono avvicinata alle grate ed ho potuto vedere molti dei miei amici che mi domandano come stavo. Ho detto loro che stavo bene e che ci portavano alla migrazione di Toluca.
Loro mi dicono che mi seguiranno che non mi lasceranno sola. Mia zia Monica mi passa una busta che contiene i miei documenti migratori e María Novaro, la mia insegnante e mamma in Messico, mi dà un giubbotto per il freddo. Così salgo sul veicolo che chiude le porte e ci porta via. Siamo andati in un ufficio a Toluca a cercare una funzionaria e da lì ci hanno portato alla stazione migratoria nel DF.
Siamo arrivati alla stazione migratoria alle tre del mattino. Una volta lì, malvolentieri un medico ha constatato le ferite. Abbiamo un po’ sonnecchiato perché quando siamo arrivati non era orario d’ufficio e non c’erano molti funzionari sul posto. Alle 7 del mattino ci hanno portato cereali con latte.
Poi hanno preso la mia deposizione ed oltre a chiedere i miei dati personali, mi hanno fatto domande del tipo: “conosci l’EZLN?”, “sei stata alla Città Universitaria?”, “hai partecipato al Forum Mondiale dell’Acqua?”, “conosci gli altri stranieri fermati?”, ecc.
Ho firmato la deposizione a cui è stato allegato il mio documento migratorio, una lettera del mio centro studi, una lettera della mia insegnante María Novaro, il mio passaporto, il mio certificato di identità cilena e la mia credenziale internazionale di studente. In quel momento ricevo una chiamata dal console del Cile in Messico, che mi domanda il mio nome, il numero del mio certificato di identità e se ho qualche parente in Messico. Mi informa che quello che lui può fare è che tutto si svolga in condizioni legali.
Ripeto la mia deposizione e si ripetono le domande sull’EZLN, il subcomandante Marcos ed Atenco. Nel frattempo fuori della stazione migratoria si erano riuniti amici e familiari con i quali non mi è permesso di comunicare. Ho tentato di farlo con segni e cartelli ma anche questo ci è stato impedito.
Mi portano in una stanza dove ci sono tre uomini che mi dicono che sono lì per aiutarmi. Mi fotografano davanti e di profilo e registrano ogni momento della conversazione. Mi domandano il mio nome e se ho un soprannome, se conosco l’EZLN, se sono andata nella Selva Lacandona, di fornire nomi che possano dare precedenti su di me che tipo di documentari voglio realizzare.
Mi dicono che la mia amica América del Valle è preoccupata per me, perché mi ero persa mentre scappavamo dal posto, persona che, solo arrivata in Cile, ho saputo essere una delle dirigenti di Atenco che la polizia persegue.
Alla fine dell’interrogatorio, con una macchina molto sofisticata mi prendono le impronte digitali. Mi portano fuori della stanza e mi portano in un’altra dove ci sono tre visitatrici della Commissione Nazionale dei Diritti umani e dopo che le due spagnole ed io abbiamo raccontato loro quello che abbiamo vissuto, ci raccomandano di chiedere immediatamente l’assistenza di un avvocato per presentare un ricorso nel caso di una possibile espulsione. Il clima è teso e chiedo ad uno degli avvocati una penna ed un foglio per scrivere “avvocato” e mostrarlo attraverso la finestra ai miei amici che stanno fuori. In quello momento, entra un funzionario di migrazione e vedendomi scrivere mi dice: “Hai bisogno di un avvocato? Io sono avvocato, quale è il tuo problema?”. Gli rispondo che voglio presentare un ricorso e lui mi risponde che non è opportuno presentare un ricorso implicherebbe rimanere nella stazione migratoria per un mese e che molto probabilmente presto sarei stata rilasciata. Le visitatrici dei diritti umani lo riprendono e gli dicono di lasciarmi parlare con qualcuna delle persone che stanno fuori.
La visita è concessa e parlo con Berenice con la quale mi lasciano parlare per cinque minuti. A lei dico che ho bisogno di un avvocato e mi dice che c’è già. La saluto bruscamente e poi mi portano ad una visita medica per la seconda volta in questa stazione migratoria. Mentre mi stanno visitando arriva un funzionario ad interrompere la visita e mi dicono che mi portano in un altro posto, io chiedo dove ma non mi viene data risposta.
Uscendo dall’ambulatorio incontro una delle visitatrici dei diritti umani e le dico, per favore, di avvisare i miei amici che stanno fuori che mi stanno portando via. Domando al funzionario dove mi portano e mi risponde agli uffici centrali di migrazione. Non mi lasciano continuare a parlare con lui e mi fanno salire su un’auto privata dove trovo Mario, il mio compatriota.
Salgo, salgono tre poliziotti, si chiudono le porte ed un poliziotto chiede di chiudere i finestrini. I cancelli della stazione migratoria si aprono e l’auto sgomma fuori come fuggendo da qualcosa. Abbiamo percorso il periferico in mezzo al traffico a oltre 100 km all’ora.
Domando dove ci stanno portando e non ottengo risposta. Durante il tragitto mi accorgo che stiamo andando all’aeroporto e che davanti a noi ci sono altre due auto; una con Samantha, la tedesca ed un’altra con María e Cristina, le due spagnole.
Davanti all’imminenza dell’espulsione ingiustificata non mi rimane altro che chiudere gli occhi e stringere i denti e pensare: un’altra violenza in più.
Arriviamo all’aeroporto alle 6 del pomeriggio. Ci fanno scendere dalle auto e ci portano scortati in una sala completamente bianca dove ci trattengono per più di un’ora. Poi ci portano nelle sale d’attesa all’interno dell’aeroporto, sempre scortati. Per primo parte il volo di Samantha. Aspettiamo e nell’attesa io non faccio che piangere. Mi sento male. Tento di camminare per il corridoio. La guardia mi dice che devo stare seduta. “Mi sento male”, gli dico. “Non scappo, lasciami camminare”.
Continuo a piangere ed un poliziotto si avvicina e mi dice: “Non fare così. Non ti conviene. Se ti può consolare, ti dico che non sei deportata ma sei stata solo espulsa dal paese, ma potrai ritornare in qualsiasi momento”. Ingenuamente le sue parole mi tranquillizzano.
Ci portano in un bar a fumare una sigaretta perché tutte siamo molto nervose. Viene annunciato il volo di Lan Chile, delle undici della sera. Chiamano me e Mario. Salutiamo María e Cristina con un forte abbraccio. Ci mettiamo in fila e saliamo in aereo.
In aereo, uno dei passeggeri mi si avvicina e mi consegna delle lettere che hanno mandato i miei amici che stavano fuori a fare tutto il possibile per fermare questa ingiusta espulsione. Piango di commozione nel sapere che non sono sola. La guardia al mio fianco mi chiede che succede. Le racconto il mio caso. Le dico che vivo in Messico da 11 anni che la mia vita è in questo paese, che non mi è mai stato detto quello che stava succedendo, che tutto il procedimento è stato illegale che sono stato picchiata e vessata dalla polizia.
Mi dice che a lei l’hanno avvisata 30 minuti prima di salire sull’aeroplano che sarebbe andata in Cile, che non le hanno spiegato niente, ma che aveva notato qualcosa di strano nella procedura perché normalmente prima di espellere qualcuno passa minimo un mese nella stazione migratoria, che deve esserci stato un ordine dall’alto.
Orami conscia dell’espulsione, mi metto a parlare con lei e le dico che posti di Santiago può visitare nel breve tempo della sua permanenza. La stanchezza e l’impotenza sono grandi. Mi addormento. Mi sveglio sulla cordigliera delle Ande dai finestrini dell’aereo. Scendiamo dall’aereo. Ci consegnano alla polizia internazionale dove prendono la nostra deposizione sul perché della nostra deportazione e/o espulsione.
Fuori mi aspettava la mia famiglia. Pianti, baci, abbracci. Andiamo all’ospedale a controllare le ferite e, rapidamente, organizziamo una conferenza stampa con radio e televisione dove denunciamo l’illegalità della nostra espulsione e la brutalità poliziesca della quale siamo stati oggetto.
2.- Dopo quello che vi ho raccontato vorrei mettervi a conoscenza del mio totale rifiuto, indignazione e rabbia per quanto segue:
- L’utilizzo della violenza fisica, psicologica e sessuale, come arma di tortura e coercizione contro le donne.
- La brutalità poliziesca della quale sono stati oggetto tutti i detenuti, al di là della nostra nazionalità.
- L’illegalità della mia espulsione in due sensi: per essere in possesso di documenti di migrazione in regola e per il non accoglimento del ricorso presentato, argomentando la mia assenza nel paese quando io ero ancora in Messico.
3. – Per quanto detto sopra, stiamo studiando con i nostri avvocati le azioni per conseguire i seguenti risultati:
- Ci venga restituito il diritto di studiare in Messico, attraverso ogni tipo di intervento con il governo cileno e messicano.
- Azioni a livello diplomatico con l’ambasciata del Messico in Cile.
- Presentare denuncia penale contro la polizia per procurate lesioni.
- Presentare appello contro lo stato messicano per deportazione illegale.
Non alla violenza, non all’uso di donne e uomini come oggetti! Non alla brutalità e alla tortura! Non alla giustificazione della violenza!
Valentina Palma Novoa
Fai clik qui per altro ancora dell’Altro Giornalismo con l’Altra Campagna
Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch
For more Narco News, click here.




